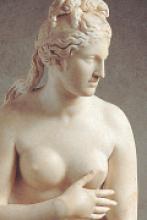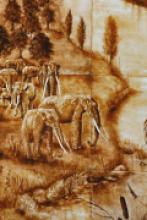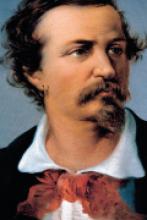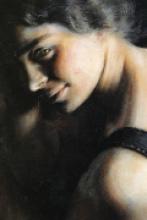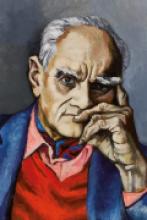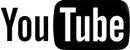Una lettura antropologica
Si attribuisce alle opere di Ettore Roesler Franz un indubbio valore documentario, non soltanto per quanto riguarda le ristrutturazioni urbanistiche iniziate dopo il 1870, ma anche perché in esse l’autore descrive con sensibilità etnografica le molteplici attività della vita quotidiana di una Roma ancora a dimensione di paese, ovvero quei saperi e abilità popolari che furono per lungo tempo efficaci strumenti dell’agire quotidiano.
Nella I Sala, dedicata al fiume Tevere, spiccano i mestieri e le attività legate al fiume che rappresentava in quegli anni la più importante via di comunicazione attraverso la quale arrivava in città, con barche o zatteroni, ogni tipo di merce. I porti fluviali di Ripetta e di Ripa Grande erano luoghi di grande traffico: in quello di Ripetta approdavano le merci provenienti dalla Sabina e dall’Umbria come l’olio, il frumento o il vino; mentre il porto di Ripa Grande era aperto ai grandi traffici del mare Mediterraneo. Il pesce pescato, portato soprattutto al mercato di Portico d’Ottavia, era venduto all’ingrosso (“cottìo”). La vendita si svolgeva in forma di asta secondo modalità tradizionali. Per le contrattazioni venivano usati termini gergali comprensibili solo ai “cottiatori” e agli acquirenti: venditori al minuto, trattori, cuochi delle grandi famiglie romane. La paìna per esempio era il prezzo complessivo del pesce acquistato da un pescivendolo in una settimana, mentre “ingrandire uno” significava vendergli pesce non fresco. Il mercato del pesce era particolarmente affollato la vigilia di Natale, poiché la tradizione imponeva che la cena fosse a base di pesce e verdure. Oltre ai pescatori il Tevere dava lavoro a barcaioli, traghettatori, molinari (gli addetti ai molini ancorati alle sponde del fiume, dove avveniva la macinatura del grano), scaricatori, marinai e operai dei porti. Ma il Tevere era importante anche per le attività di svago praticate nel tempo libero dai romani. Agli inizi del 1883 si era costituita la società di Ginnastica dei Canottieri del Tevere, seguita nel 1884 dal Club del Remo. Avevano tutte carattere di èlite, con alla presidenza alcuni principi romani. I ragazzi, invece, nonostante le severe sanzioni proclamate da editti pontifici, continuavano a fare il bagno nudi nel fiume, mentre le rive ombrose e ricche di vegetazione erano la meta preferita dagli innamorati.
Nella II Sala sono raffigurati mestieri e attività di pertinenza femminile (filatura, rammendatura, lavatura dei panni, cernita e preparazione iniziale dei cibi) e maschile (maniscalco, capraio, ombrellaio); i vari sistemi di trasporto: umano, nella duplice tipologia sulla testa e sulle spalle, o a trazione animale con i vari tipi di carro. In molti acquerelli sono raffigurati i panni stesi alle finestre con il sistema tradizionale, vale a dire appesi inserendone gli angoli in piccoli cappi di corda che pendevano dalla corda principale. Numerosi sono anche i particolari dell’arredo urbano come le targhe stradali (allora in gran parte dipinte sui muri), i manifesti elettorali (a testimonianza delle importanti trasformazioni nella vita politica di quel periodo), le insegne delle botteghe e le osterie, queste ultime segnalate da una frasca (un ramo piuttosto consistente di alloro o edera), oppure da una bandiera rossa, da un cerchione di botte o da una ruota di carro. Infine sono rappresentati aspetti della devozione popolare come le edicole votive, dette “madonnelle”, alle quali si chiedeva protezione dalle malattie, dalle disgrazie o dai pericoli. Erano poste sulle facciate delle case o in corrispondenza di incroci circondate da ex-voto anatomici, d’argento o di latta, a forma di cuore o di altre parti del corpo, oppure ex-voto figurativi come le tavolette dipinte raffiguranti l’intervento miracoloso. Il lume che ardeva davanti alle edicole votive rappresentava l’unica illuminazione notturna delle strade romane.